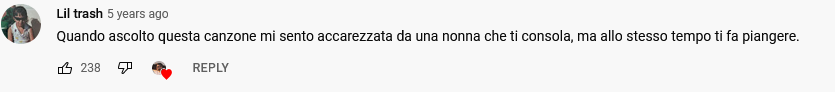Senti Cristina, io sono molto stanco. Io ho quasi 50 anni e ho la casa mezza sfondata, questo non sarebbe grave però eh, la cosa grave è che qui a me mi stanno facendo fuori, hai capito? Io presto dovrò reinventarmi tutto e credimi che a 50 anni non è facile. Tu sei una ragazza giovane, tu prendi 200 mila euro per sei mesi di lavoro, quando c’è gente che per mille euro al mese sfonda le strade col martello pneumatico senza battere ciglio e lotta per vivere una vita di merda. Io penso che sarebbe bello per una volta vedere le cose nella giusta ottica, no? eh? E fare semplicemente il proprio dovere, senza capricci, senza problemi. In questo caso piangendo, se è il caso di piangere.
…
Hai finito d’attaccarmi la pippa Renè?
Boris è stato un fenomeno difficilmente spiegabile. Come molte cose che succedono nel nostro Paese non è stato parte di un movimento coerente ma un’incredibile eccezione. È stata una serie di qualità, per gli attori, per la regia, per la sceneggiatura: si è pienamente adeguata agli standard internazionali delle serie tv (che in realtà sarebbero venuti dopo) pur mantendendo dei contenuti molto italiani, italianissimi. Infatti, per quanto ben realizzata, Boris per essere fatta capire a un pubblico straniero avrebbe bisogno di un corso propedeutico di usi e costumi italiani, una sorta di Cura Ludovico, solo per avere i requisiti per apprezzarla davvero.
Intendiamoci, Boris parla di televisione e cinema, quindi prima di forzare troppo l’allegoria è giusto tenerlo a mente. Tuttavia riesce a fare magistralmente qualcos’altro: spiegare il nostro Paese. Non attaccandoci la pippa su tutto ciò che non va, ma raccontando le disfunzioni nostrane in maniera sottile e sussurrata, a volte con una semplice smorfia. Per dirla terra terra, Boris è come avere il C2 di una lingua straniera: lo so che la sai, quindi è inutile che ti spiego le basi della grammatica per comunicare. Passiamo direttamente ai dettagli. Lo spezzone trascritto qualche riga più sopra è esemplificativo di tutto ciò. In realtà è solo uno tra le centinaia che potrebbero essere presi e passati al setaccio alla ricerca di significati nascosti eppure, questo trasmette alla perfezione il livello di meta-italianità che la serie raggiunge. È una sorta di Stele di Rosetta per chi vuole davvero capire cosa significa essere molto italiani, sia negli aspetti folkloristicamente socio-politici ma anche, e soprattutto, nel sentimento che mettiamo nella nostra vita da mediterranei.
Senti Cristina, io sono molto stanco. Quando Renè inizia il suo discorso, la trasmette davvero, questa stanchezza. Inizialmente prende un respiro e fa una smorfia di impazienza mista a rancore. Poi però si rende conto che non ha la forza di arrabbiarsi e così, calcando la mano sul volto, si toglie metaforicamente la maschera, mettendo a nudo la sua vulnerabilità. È evidente che non si tratta di una stanchezza meramente fisica ma di fatica derivante da una frustrazione perenne, che lo accompagna ogni giorno sul set. La fatica di Sisifo, per intenderci: quella del reiterare uno sforzo disumano pur sapendo che non sfocerà in un successo. È probabilmente quella che lui prova lavorando come regista, il lavoro di uno che ha in mente un’idea che solo gli altri possono realizzargli.
Io ho quasi 50 anni e ho la casa mezza sfondata, questo non sarebbe grave però eh. Appena inizia il suo sfogo, Renè attinge alla sua vita personale, in una breve digressione che si dissolve quasi istantaneamente. In primis, solleva la questione dell’età, che in effetti è un incipit molto italiano quando si discute: di solito viene usata come artificio dialettico per sbattere in faccia all’interlocutore la propria esperienza; in questo caso, sembra più un voler corroborare la questione della stanchezza, che si sopporta sempre meno con l’incalzare degli anni. Poi cita un dettaglio apparentemente fuori luogo in quel momento, quello della sua casa-mezza-sfondata: sembra uno di quei pensieri che rimangono tra i processi in background nell’inconscio di qualcuno, così poco rilevanti per tutti tranne che per se stessi. D’altronde parliamo della casa, quasi certamente di proprietà, uno dei pilastri dell’identità nazionale. Poi però Renè interrompe bruscamente questo accenno di flusso di coscienza. Per chi non sarebbe grave, però? Per Cristina che lo ascolta, perché si rende conto di star condividendo frammenti della sua vita che così poco le interesserebbero, o è un promemoria per se stesso, perché si sta rendendo conto di divagare, anche se è ben conscio del fatto che nella scala delle priorità il suo problema più pressante è la casa e non i capricci degli attori?
La cosa grave è che qui a me mi stanno facendo fuori, hai capito? Nella maggior parte della serie, Renè oscilla tra la paura e il sollievo all’idea di perdere il lavoro. Tuttavia in quanto regista di fiction, il suo è più che un semplice lavoro: è anche una questione di politica. È quel “mi stanno facendo fuori” che preoccupa Renè, ancor più della casa mezza sfondata. È forse la prospettiva di essere sollevato dal suo incarico senza averlo potuto fare prima lui, di sua iniziativa. Il togliergli la soddisfazione di liberarsi di una cosa che in fondo odia, ma che deve fare costretto da non si capisce bene chi o cosa: se dal bisogno di soldi, dal senso del dovere (il lavoro visto come una cosa da fare anche se non ci piace, altra cosa molto italiana) o da un sadico piacere di girare la monnezza, come la chiama lui.
Io presto dovrò reinventarmi tutto e credimi che a 50 anni non è facile. A volte un talento – o un’opportunità – è una condanna. Renè gode della stima di molti degli addetti ai lavori, per quanto nei suoi scorci di biografia si citino solo cose di cui si vergogna di aver girato. A Renè piace il set, come a un atleta piace l’odore del campo in cui entra durante la partita. Probabilmente è questo ciò che accomuna tutti: si inizia col fare una cosa che si ama e si finisce per odiarla, a forza di seppellire la passione sotto una valanga di compromessi. Renè sa che per quanto se ne lamenti, stare sul set è la cosa che gli riesce meglio. Mettersi a fare qualcos’altro non rappresenta una nuova prospettiva ma un salto nell’ignoto. Cambiare lavoro a volte spaventa più che perderlo.
Tu sei una ragazza giovane, tu prendi 200 mila euro per sei mesi di lavoro, quando c’è gente che per mille euro al mese sfonda le strade col martello pneumatico senza battere ciglio… A questo punto Renè si rivolge finalmente a Cristina e si arriva al cuore del discorso. Vuole farle pesare tutta una serie di cose: che è giovane, quindi per definizione fortunata e senza problemi agli occhi di qualcuno non più giovane, e che è privilegiata, per quello che prende in virtù del poco che fa. Renè è consapevole che fa parte del gioco, ma forse non si capacita ancora del perché le persone con cui ha a che fare prendano più di lui faticando molto meno. Per quanto classico sia questo pattern (c’è sempre qualcuno che si fa il mazzo più di noi, e bisogna compatirlo) nel tono di Renè non c’è volontà di umiliare, ma una disinteressata intenzione di istruire. L’esempio di chi fa lavori di fatica prendendo una paga misera è un clichè, certo, eppure risulta particolarmente efficace considerando il contesto – d’altronde Renè non sembra dirlo come frase di circostanza, ma con la consapevolezza di uno che, magari in gioventù, ha davvero fatto lavori umili prima di avere successo. È in questo momento che Cristina dimostra già cosa pensa di questa conversazione. Quando alza gli occhi al cielo, non li abbassa con il fare di qualcuno che ha incassato la parternale e ne farà tesoro, ma con l’impazienza di chi ha deciso di non ascoltarti fin dal principio.
…e lotta per vivere una vita di merda. Renè conclude così il suo pensiero sui privilegi e chi non ne ha. Lo fa con un’uscita di getto, che però spiazza per il suo pathos. Lottare per vivere (comunque) una vita di merda. Nell’ideale di lotta che abbiamo, gli sforzi profusi, nel lavoro, nello studio, nella vita, non sono mai vani, perché la fatica di oggi è il successo di domani. E invece no, perché non sempre sforzandosi si raggiunge l’ottimo. Queste poche parole messe in quest’ordine aprono un universo, sul nostro Paese e sulla vita in generale: dal dibattito sulla decennale scarsa produttività nazionale, all’etica del lavoro di matrice cattolica, che sembra finalizzata quasi esclusivamente a martoriare il proprio corpo senza possibilità alcuna di emancipazione. E questa frase riesce a fartela davvero immaginare, questa lotta: la senti, te la immagini come una lunga giornata che termina accasciandosi sul divano, sul quale ti assopisci in cinque minuti dopo aver acceso la televisione. Una giornata non rilevante, che ha il solo pregio di essere finita.
Io penso che sarebbe bello per una volta vedere le cose nella giusta ottica, no? eh? Quel “no? eh?” conclude tutta la riflessione di Renè tramutandosi quasi in supplica. È la speranza di aver fatto capire il proprio punto di vista a qualcuno, con così poche parole – perché alla fine le parole sono sempre poche. Ma è anche un tentativo disperato. Quante volte ci proviamo a metterle nella giusta ottica, le cose? Quante volte proviamo a farlo capire agli attori, ai calciatori, ai politici? Però ci viene anche un dubbio lecito: ma esiste un’ottica (ed è fisicamente un’ottica?, semicit.) e per di più giusta? Per chi? Forse non è chiara perché nessuno parla mai dell’ottica di chi li prende, questi 200 mila euro in sei mesi, visto che sarebbe un punto di vista un po’ impopolare. Infatti Cristina non vede cosa dovrebbe fare di diverso e di sicuro non vede perché dovrebbe impietosirsi.
E fare semplicemente il proprio dovere, senza capricci, senza problemi. Una delle poche volte che Renè è felice, così tanto da sorprendersi, è quando l’attrice che fa il ruolo della magistrata si comporta semplicemente da professionista, recitando come da copione. Come regista, si trova quasi sempre solo nel mare in tempesta e il suo principale compito è quello di chiedere a chi gli sta intorno di fare il proprio lavoro, senza neanche pretendere di farlo bene. Eppure quello di Renè è anche un desiderio, per quanto lecito, fin troppo naïf. Tutti vorremmo ottenere le cose che vogliamo senza ricevere una reazione uguale e contraria da parte di chi ne vuole altre, spesso in antitesi alle nostre. In un contesto più drammatico, ricorda il Sindaco di Los Angeles durante la tragica rivolta del 1992: can’t we all get along? Un tentativo così ingenuo e disperato al quale però facciamo fatica a dare torto.
In questo caso piangendo, se è il caso di piangere. Renè torna al pomo della discordia: Cristina non voleva piangere nella scena che stava girando. Eppure, alla luce di quanto detto prima, forse non è più una questione di recitazione. Forse quello che non riesce a far piangere Cristina è il non averne mai avuto bisogno, mentre Renè scoppierebbe proprio mentre finisce di parlare, per la stanchezza e la frustrazione, e per questo non si capacita di cosa ci sia di così difficile nel farlo.
Hai finito d’attaccarmi la pippa Renè? In realtà era chiaro che questa cosa Cristina la stesse già pensando dall’inizio della conversazione. Renè ha parlato a cuore aperto ma sollevando temi di scarsissimo interesse per una nella posizione di Cristina. In quel momento, spiazzato da tanta sfacciataggine, Renè le dà uno schiaffo. La scena rende alla perfezione il valore di quel gesto: la violenza come mancanza di alternativa alle parole, un bisogno di contatto fisico in sostituzione di un ponte verbale che non è stato possibile erigere – ti meno perché almeno senti (sentirmi inteso come ascoltare ma anche come percepire), legittimo con la violenza la mia presenza ai tuoi occhi. È uno schiaffo punitivo, quasi genitoriale, che sanziona un’impertinenza ingiustificabile. Ma per assurdo è solo un ulteriore, vano tentativo: Cristina reagisce con gli interessi, rispedendo al mittente anche quest’ultima prova di stabilire un contatto. Insomma, tutto ciò non è servito a niente.